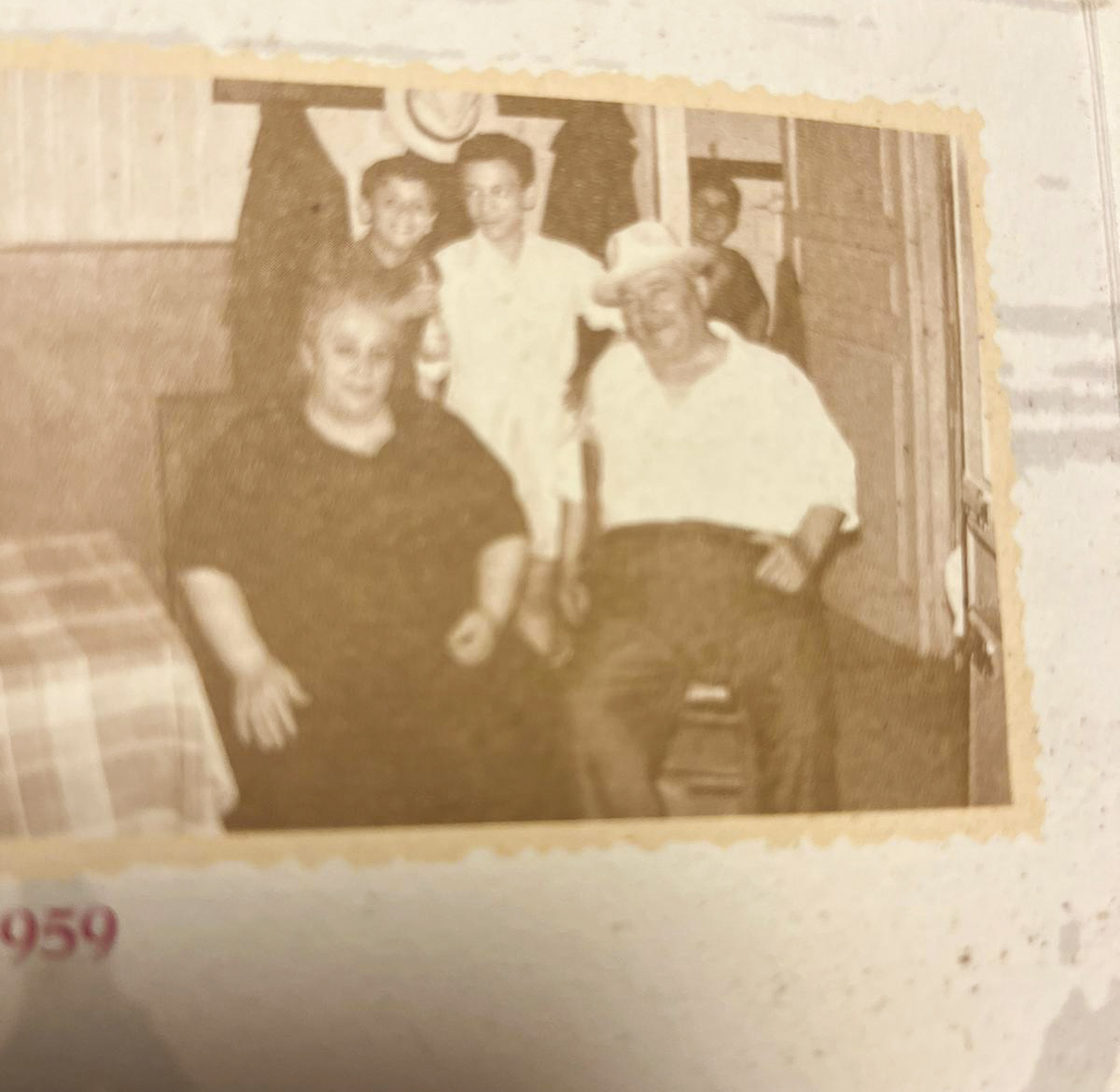La Marchesella Gena Iodice
Una cuoca nella terra del Basile
C'era una volta, in quel di Giugliano in Campania, una ragazza di nome Luisa, che tutti chiamavano Luisella, classe 1900. Era bella. Di una bellezza genuina, abbondante come la sua generosità. Veniva da una famiglia agiata, dove non mancava nulla: terreni, istruzione, benestare. Un giorno conobbe Andrea, classe 1898, che invece, era un contadino, un uomo d'ingegno, con poco in tasca ma con una volontà di ferro. I due si innamorarono e lui, convinto che ella dovesse diventare sua moglie, andò dal padre di Luisella e, con tanto coraggio, gli disse: “Si nun m’a date, je m’a fuje...”. La cosiddetta “fuitina” sarebbe stata una vergogna per la famiglia ma il padre di Luisella, con il cuore diviso tra orgoglio e amore, disse: “Con tutto il mio amore, mi farebbe troppo male. Dio vi benedica”. Erano due mondi diversi. Lui una persona perbene, ma senza istruzione; lei, abituata all'agiatezza. Andrea possedeva una cantina, che durante la guerra divenne un rifugio per tante persone impaurite. Lì, dove si rifugiavano e sostenevano, crearono 'na cucinella, dove Luisella preparava fasul cavere, 'nu poco 'e brodo, ‘o decotto e mele per tutti. Ad un certo punto, ad Andrea sovvenne un’idea, la guardò e le disse: “ma visto che tu cucini accussì buon, pecché nun o facimm diventà 'nu lavoro?”
(Visto che tu cucini così bene, perché non ci trasformiamo in osti?, ndr).
Si erano già sposati, la casa c'era già e le possibilità pure: bastava aprire le finestre e lasciar entrare il profumo del cibo. E così nacque “Fenesta verde”, trattoria e osteria dal 1948. Sembra una favola de “Lo cunto de li cunti” di Giovambattista Basile, che proprio in questa città alle porte di Napoli fu scritto ma è, invece, pura realtà. Il loro cibo iniziò a farsi un nome. Il mercato ortofrutticolo di Giugliano – un tempo conosciutissimo – era un via vai continuo di commercianti, calabresi, siciliani e non solo, uomini affamati che cercavano un posto dove fermarsi.
(Visto che tu cucini così bene, perché non ci trasformiamo in osti?, ndr).
Si erano già sposati, la casa c'era già e le possibilità pure: bastava aprire le finestre e lasciar entrare il profumo del cibo. E così nacque “Fenesta verde”, trattoria e osteria dal 1948. Sembra una favola de “Lo cunto de li cunti” di Giovambattista Basile, che proprio in questa città alle porte di Napoli fu scritto ma è, invece, pura realtà. Il loro cibo iniziò a farsi un nome. Il mercato ortofrutticolo di Giugliano – un tempo conosciutissimo – era un via vai continuo di commercianti, calabresi, siciliani e non solo, uomini affamati che cercavano un posto dove fermarsi.